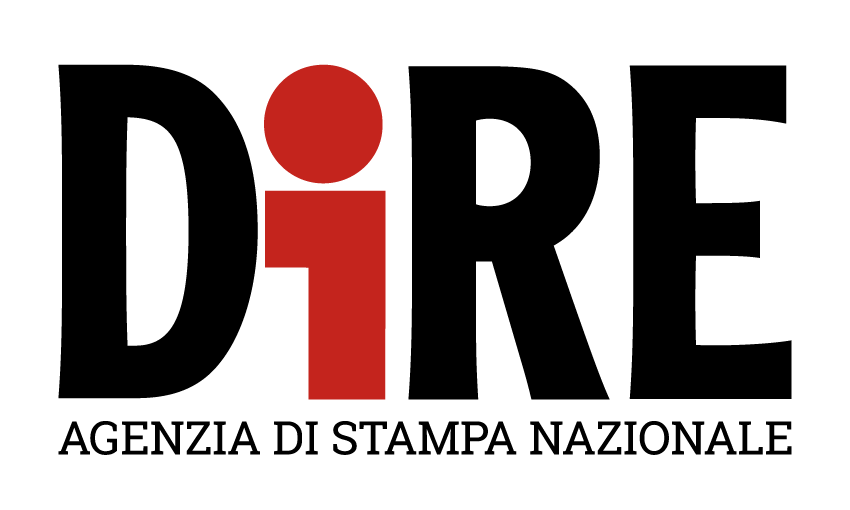Era sempre andata così con lei. Litigavamo per nulla ed eravamo capaci di non parlarci per giorni. Eravamo capaci di offenderci, di odiarci, di urlarci contro parole incomprensibili. Potevamo far finta che non ci fosse mai stato niente tra di noi, ma non ci riuscivamo mai. Perché sì, il nostro rapporto è stato un errore, uno stupido incidente di percorso, ma ci siamo tanto amati a nostro modo. Perché dopo ogni litigata finivamo per abbracciarci, come se niente fosse accaduto. Ci stringevamo forte, come per non farci scappare quel momento in cui sapevamo che ciò che ci aveva unito era più forte di quello che ci aveva messo l’uno contro l’altro. Era la mia migliore amica dopotutto… lei era tutto per me.
Ci siamo incontrati per caso… beh, tutto ciò che ci ha riguardato è accaduto come una sola e grande coincidenza. Avevo appena cambiato scuola: nuova classe, nuovi professori, nuovi compagni di classe. Ma detto così sembra banale, una sciocchezza, ma la situazione è davvero più complicata di quello che si potrebbe immaginare. Oggi cambiare scuola vuol dire cambiare cerchia, trasmigrare in un altro punto di questa dimensione vuol dire mettere in pericolo la propria famiglia. Viviamo in una società che non accetta il diverso, purtroppo, una società fondata sulla più completa anarchia. Ed è tutta colpa dell’Uomo. Lui ha deciso di creare questo mondo, un mondo bianco dove lui un giorno ha deciso di far piovere pioggia d’inchiostro, dandoci così la vita. Sì, perché noi siamo nati così: siamo frutto dell’immaginazione di un unico e solo individuo, che ha ormai già scritto il nostro destino. Spesso però accade che ciò che ha scritto non venga portato a termine, e così tutti i personaggi di quella cerchia alla quale aveva dato inizio finiscono abbandonati o peggio. A volte vengono ripresi e trasferiti in un’altra storia. Ed è quello che è successo a me. Io ero nato per fare l’astronauta. Non ho mai avuto dei genitori, ero semplicemente stato adottato da un capitano di una stazione spaziale che mi aveva allevato nel tentativo di mandarmi, un giorno, nello spazio. Ma prima che io venissi spedito su, verso quel cielo stellato, la penna si fermò, la linea del mio destino si interruppe bruscamente e un forte stridio, come quello di un tuono secco, si fece avanti nella mia testa. La pianura bianca nella quale mi trovavo pronto al decollo, e che Voci dicono chiamarsi Pagina, venne percossa da una forte scossa e un divario profondo si aprì sotto di noi. Molti di noi vennero divorati da quell’immenso cratere e caddero verso il basso, dimenticati da tutti. Io ero rimasto lì, intrappolato nel mio razzo. Non so cosa fosse ben successo dopo. Mi ricordo che la mia vista si era appannata e che i miei occhi erano rimasti chiusi per tanto tempo. Nella mia vecchia cerchia, quella fantascientifica, avevo avuto modo di conoscere la storia di chi precedentemente aveva vissuto in una dimensione storica, cavalleresca oserei dire, chi invece aveva visto paesaggi in rima e chi aveva attraversato una vita immersa nel più completo incubo. A me piacevano le loro storie, ma non potevo andarlo a dire in giro. Il fatto che un personaggio fosse stato protagonista per più di una volta, magari avendo anche avuto esperienza migliori dei nativi di una cerchia, che avesse visto un mondo diverso, che fosse stato magari reso anche reale attraverso quelle immagini in movimento… non era una cosa di cui andare molto fieri, si veniva puniti non solo con l’esclusione dalla comunità ma anche con la privazione di tutti i vantaggi che la società offriva. Perché era come se avere un passo in più fosse un reato.
Quando avevo riaperto gli occhi mi trovavo in un posto completamente diverso. Non c’erano più le stelle in cielo, solo una nebbia triste. Non so come spiegarlo. Prima tutti sorridevano, esultavano. Nonostante i vari problemi eravamo tutti felici, accettavamo ciò che ci veniva dato. Ora tutto era precipitato. Non c’era un anima in giro e quei pochi che si incontravano se ne stavano in un angolo del bar a bere un caffè e ad ascoltare musica, con nemmeno un’ombra di sorriso. Pioveva a dirotto e a ogni goccia c’era una lacrima che solcava il viso di qualcuno. Non so cosa fosse successo. Le solite Voci dicevano che l’Uomo era caduto in un brutto periodo, del quale non volevano fare il nome, e che ora trasferiva tutto quanto il suo dolore in noi, senza un motivo preciso. Se non avesse voluto soffrire da solo o se invece non fosse stata sua intenzione non lo sapevano neanche loro. Ma ormai la situazione era questa, non ci si poteva fare niente.
Qualche giorno dopo la mia rinascita, avevo finalmente tutto chiaro: ero magicamente ringiovanito di una ventina d’anni, mi trovavo in una cerchia strana, sai, quella sulle storie tristi, quelle che finiscono con assurde delusioni. Arrivato nella nuova classe, tutti mi avevano squadrato da capo a piedi. La prima impressione era quella di non piacere a nessuno, ed infatti non mi ero sbagliato. Ormai lo sapevo che non avrei trovato neanche un amico, non con il mio passato. Poi arrivò quel momento: a ricreazione corsi vero la macchinetta del caffè e mi scontrai con una ragazza. A lei caddero i libri di mano, pronunciò un “ops” timido, appena accennato. Non alzò nemmeno lo sguardo su di me, ma il viso le si arrossì lo stesso. I capelli le coprivano gli occhi, ma ormai volevo fare conoscenza di quella piccola anima fragile. Qualcosa, nell’osservarla, mi diceva che sarebbe stata una cosa sbagliata, ma io volevo farlo. Le presi i libri da terra e, porgendoglieli, le chiesi come si chiamasse. Si sistemò i capelli dietro le orecchie e un po’ goffamente mi rispose “Emily”. Qualcosa in quel nome, oppure in quella voce, mi aveva colpito nel profondo. Le sorrisi e iniziai a chiederle se avesse degli amici, la vedevo un po’ sola, dopotutto. Mi rispose che purtroppo nessuno aveva mai avuto interesse a conoscerla: stava molto tempo sui libri, non era molto sociale né interessante. Lo scrittore aveva voluto così, che vivesse da sola. “Per il momento”, pensai. Così, fidandomi, iniziai a parlarle di me. E poi una parola tirò l’altra e in poco tempo ci eravamo ritrovati a stringere un legame forte e particolare. Quel pomeriggio decisi di riaccompagnarla a casa. Rideva così forte con me, anche per le più piccole battute. Capivo che le piaceva avere qualcuno che le parlava e che non era abituata a qualcosa di simile. Poi si fece seria tutta di un colpo.
– Sai – iniziò a dire – ho paura. Non sono mai stata così bene, neanche con me stessa. Da che mi ricordi io non sono mai piaciuta agli altri, e questo mi ha fatto odiare me stessa. Mi sentivo sbagliata per questo, fuori posto, capisci? E il fatto che ora l’Uomo abbia voluto cambiare la cosa di punto in bianco, non so, mi fa preoccupare. E se poi mi farà stare male di nuovo? Io ho paura di lui, l’Uomo sa essere davvero perfido! –
Aveva cominciato ad accennare a delle lacrime, ma io non volevo che piangesse. La presi per le spalle, la guardai negli occhi e le promisi che sarei andato contro il volere dell’Uomo stesso pur di non farla soffrire.
– Lo so – le dissi – ci conosciamo da poco, ma tu… non lo so, ma meriti davvero tante e cose e poi entrambi abbiamo un motivo valido per non lasciarci andare – non continuai la frase: avevo paura di dire qualcosa di inopportuno, promettere qualcosa che non potevo mantenere perché, dopotutto, anche io avevo paura che l’Uomo rovinasse quella felicità. Ma cercavo di non farglielo notare. Cominciammo a passare ogni giorno insieme: ci piaceva uscire nel pomeriggio anche semplicemente per mangiare un gelato. Il suo preferito era quello alla crema. A volte lo prendevo anch’io, così se poi avesse avuto ancora fame glielo avrei offerto io. Spesso andavamo anche in biblioteca; stavamo in silenzio, a leggere altre avventure che invidiavamo. Ed era stato lì che, una mattina di pioggia, litigammo per la prima volta.
Era stata una giornata pesante, lo devo ammettere. Lei non era venuta a scuola e non mi voleva dire il perché. Contro di me sembrava essersi rivoltato di punto in bianco tutto quanto il mondo: ero stato picchiato, derubato, indicato come “quello diverso”. E ammetto che, arrivato alla biblioteca, ero particolarmente nervoso. Quando mi vide si avvicinò con passo deciso e mi domandò cosa mi turbasse. Non so cosa mi fosse passato per la testa in quel momento, ma le urlai. Le urlai che non poteva pretendere che io le dicessi tutto della mia vita, che io ero stanco di dover sempre cercare un motivo per tirarle su il morale quando a volte io stavo peggio di lei, che probabilmente quello che mi era successo era ben più importante di ciò che le era capitato e perciò, se lei non voleva confidarsi, io avevo un motivo in più per non farlo.
– Calmati… – sussurrò lei, con voce spezzata. E solo in quel momento mi accorsi che stava piangendo. Sul momento ero rimasto in silenzio, senza fare niente.
– Hai ragione, tutto quello che mi riguarda non ha valore. Quindi anche se mio padre è morto in guerra dieci giorni fa e anche se il suo corpo non è stato ritrovato, tutto quello che è successo a te è di sicuro più importante! E dimmi, dimmi su, cosa ti è successo, eh? Come minimo ti hanno di nuovo preso la merenda o nascosto le chiavi di casa. E poi che vuol dire che devo esser consolata? Io ho vissuto ben diciassette anni senza te e non credo di aver bisogno ora che qualcuno mi consoli, so di essere forte abbastanza per non aver bisogno di queste cose! –
Non l’avevo mai vista arrabbiata, e qualcosa dentro di me cominciava a surriscaldarsi, ma non per la rabbia, ma per la vergogna.
– Mi dispiace per tuo padre… – iniziò a dire. A quelle parole iniziò a piangere di nuovo, ma questa volta l’abbracciai. E le giornate andarono avanti così. Girate per la città, notti passate a guardare film e giorni di scuola saltati per andare a mangiare tanti biscotti e cioccolato al bar. E poi fughe al mare d’inverno, compleanni organizzati a sorpresa e piccoli regali fatti così, perché ce li volevamo scambiare. Le foto scattate di nascosto erano le più belle, perché i suoi sorrisi erano veri. Le stelle cadenti portavano nel mio spazio quel desiderio di rimanere amici per il più tempo possibile. Ma fu proprio dopo una di queste che litigammo per l’ennesima volta. Mi ero lasciato con la mia ragazza, ero disperato. Fu alla frase “ora non ho più nessuno”, che lei corse via senza dire una parola. Per un paio di giorni non si fece vedere per i corridoi a scuola né mi rispose al cellulare. Poi andai a casa sua con una confezione di gelato alla crema e, come se niente fosse lei mi strinse a sé, prese un piumone, il portatile e un cd dei Thousand Foot Krutch. Sistemò il primo sul divano, mi fece sedere e si aggomitolò vicino a me. Adoravo quando faceva così, perché voleva dire che nonostante tutto lei mi voleva davvero tanto bene, tanto da mostrarsi vulnerabile. Diede il via alla prima canzone: “So far gone”. E noi rimanemmo in quel modo, in quel silenzio che voleva dire tante cose.
Ripensare a tutte queste cose mi crea un gran senso di nostalgia. Mi piacerebbe rivivere tutte quelle litigate pur di non trovarmi dove sono ora. Perché comunque eravamo insieme.
Un giorno mi disse che mi doveva parlare. Le Voci le erano andate a fare visita a casa. Le avevano detto che lo scrittore l’avrebbe fatta morire di suicidio nel giro di tre giorni. Ma la cosa più brutta è che la causa sarei stato io. Quando me lo disse stava soffrendo tantissimo, mi ripeteva “non lo fare” tra le lacrime, ma non sapevo cosa risponderle, non sapevo cosa avrei fatto nel futuro. Era una situazione delicata, perché non potevo controllare le mie azioni, non ne ero mai stato capace. Perché dopotutto noi siamo i burattini dell’Uomo. Decisi che sarei stato a casa per quei tre giorni, ma non funzionò. Le mie gambe, al terzo giorno, cominciarono a camminare da sole, verso di lei. Quando mi vide arrivare cercò di andare via, ma non ci riusciva; era incollata al pavimento. Una volta davanti a lei volevo piangere, ma lo scrittore non era d’accordo e allora la mia faccia si era trasformata in un’orribile smorfia.
– Ti devo chiedere una cosa – iniziai a dire, lentamente e a scatti perché non volevo pronunziare alcuna parola; “ti prego no, smettila!”, mi ripetevo, ma non riuscivo a fermarmi. – Ho deciso di partire. Me ne vado a stare a Londra. Ho bisogno di prendermi un po’ di tempo per me, capisci, no? Sento che questo non è più il mio posto. Lo so che tu mi vuoi bene però… non è abbastanza, e tu lo sai. Ho bisogno di qualcuno che mi sappia amare, non semplicemente starmi accanto. E qui ormai non troverò nessuno. Ho deciso che voglio tagliare i ponti con questa vita, e tu sei quella che più mi tiene legato a tutto ciò. Quindi ti prego… no… non… mi scrive… scrivere più, nessuna lettera o messaggio. Cambierò numero di telefono e non mi va di dirti il mio nuovo indirizzo. Addio! –
Avrei voluto abbracciarla. Lei lo sapeva che io non volevo veramente quelle cose. Lei era la mia migliore amica, lei sapeva tutto di me. Mi aveva annuito guardandomi per l’ultima volta. Sapevo che non era arrabbiata con me. Sapevo che sarebbe andata via amandomi. Perché lei mi amava. Contrariamente a quello che voleva l’Uomo, lei ed io ci eravamo davvero amati. Eravamo stati gli amici più sinceri e al contempo gli amanti più disperati. Quante volte avrei voluto baciarla, dirle un “ti amo” mentre mi abbracciava, urlarglielo al posto di tutte quelle stupide litigate. Ma lei lo sapeva. In cuor suo sapeva tutto e sapeva che di nascosto, impotenti, tra tutte le urla e i gelati alla crema, noi stavamo condividendo la storia d’amore più struggente di tutte.
L’ho già detto, il nostro rapporto è stato un errore, non dovevamo innamorarci, non era questo che doveva accadere. Ma le emozioni hanno portato fuori rotta i pensieri e tutto è andato peggio di come doveva andare in realtà. Il giorno dopo, prima della mia partenza, seppi che si era impiccata. Sapevo che non mi aveva lasciato scritto nulla, l’Uomo non voleva che noi esprimessimo ciò che pensavamo a parole. Ma quel suo ultimo sguardo… Dio… i suoi occhi. Raccontavano tutto: aveva paura della morte, perché sarebbe stato un posto freddo, dove sarebbe stata di nuovo sola. Non voleva lasciarmi andare, non voleva vedermi andare via così. Aveva paura di quel punto che aleggiava sopra la sua testa. Io lo riuscivo a vedere, ed era una sensazione devastante. “Magari” pensai “ci sarà un posto anche per noi dopo la morte, dove saremo liberi”.
Era sempre stato così con lei. Litigavamo per nulla perché non trovavamo altro modo per dirci che ci amavamo per tutto.
Ginevra Comanducci
Classe 2C – Liceo Classico Statale “Galileo” di Firenze