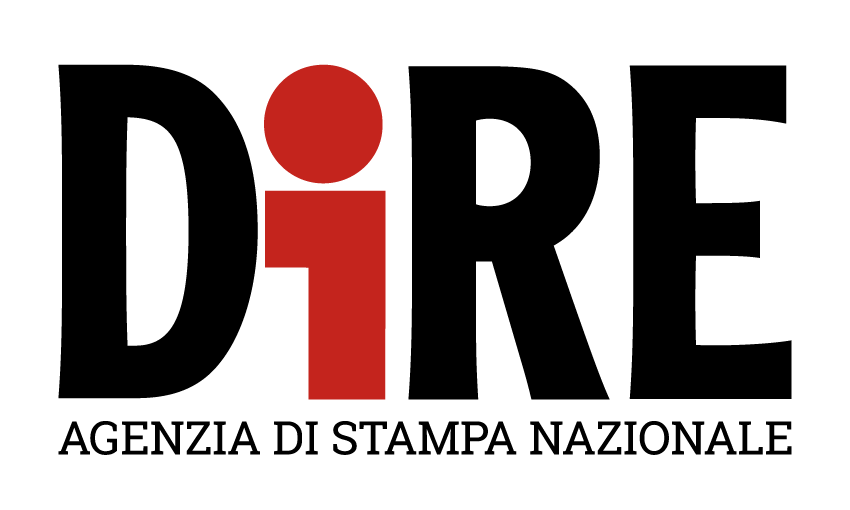“Del bellore di lei agro è l’amare”, si sentiva cantilenare nei corridoi di quel castello. Una risata grassa, fragorosa, una di quelle che scoppiano all’improvviso, risuonò dal nulla in quella stanza. Lì, al centro, c’era una piccola figura, rannicchiata, che si dondolava tenendosi strette al petto le ginocchia. Vicino a lei c’erano due… forse tre bottiglie di vino. Improvvisamente si alzò e iniziò a volteggiare nell’aria tenendo una delle bottiglie in mano, riversando gran parte del contenuto sul pavimento imbrattato e pieno di utensili arrugginiti. “Del bellore di lei agro è l’amare!”, ripetette, questa volta come se stesse urlando contro qualcuno. Del liquido rosso gli colava lungo le guance e cadeva come piccole lacrime sopra la sua camicia, un po’ più lurida e un po’ più malandata di quello che gli era permesso indossare. La figura, quel giullare, iniziò a barcollare, talvolta incespicando nei suoi stessi passi, talvolta andando a sbattere contro qualcosa della mobilia.
“Del bellore di lei agro è l’amare,
E’ lo desir dello disperato!
Caro, nel suo coraggio abrasato!
E non manca di un mal scuro canzare.”
Grifo, così si chiamava, si aggirava per quelle stanze ormai da troppo tempo. Non si staccava mai dalla bottiglia, era l’unica cosa che lo faceva ancora sentire vivo. Da quando si era suicidato tra le mura di quel castello non era mai più riuscito ad uscirne, costretto ogni sera a riprovare quel dolore che lo aveva portato ad uccidersi, quel dolore che si prova solo nel vedere il proprio amato baciare qualcun altro. E la sua Matelda, la sua padrona, ogni notte si accompagnava con un nuovo amante: quando il cavaliere, quando il libraio… ma mai il giullare. E lui era sempre rinchiuso in quella stanza, recluso con i ratti e il vino, abbastanza vicino all’ingresso per sentire camminare Matelda ogni notte prima che ritornasse alla sua torre, ma non abbastanza per vederla.
“Si Matelda volete accaisonare,
oh prencepe! Oh qual amico disformato!
Lo suo segreto tacete celato!
Nessun deve dell’avolterio servare.”
Piangeva, poi rideva. Volteggiava e poi buttava a terra qualsiasi oggetto si trovasse davanti. Si chinò per terra, con le mani sulla faccia e la camicia ormai imbrattata di un intruglio rosso, tra vino e sporcizia.
“Nessuna lagna di distramento
su desir charnagli lo cavaliere
deve far corir per lo su’ campamento.
Pura, lo so, ch’è del pensier fallimento,
nel su’ trabocchetto dovra candére.
La partita è dana del piacimento.”
Fu in quel momento che accostò l’orecchio destro, quello buono, alla porta della stanza dove era rinchiuso. Aveva imparato che ogni sera, quando la luna raggiungeva il suo culmine sopra il castello, la sua dama faceva il suo ingresso nel salone, dopo l’ennesima notte passata nella sua vecchia camera, ora vuota, prima di tornare nel luogo dove era stata rinchiusa dal popolo: la Torre dei Diavoli. E fu in quell’attimo che avanzarono lievi fruscii, simili alle piccole e fredde risatine del vento. Apparve una donna, dal viso austero a scarno, avvolta da un vestito bianco che la fasciava alla perfezione; avrebbe ammaliato chiunque anche adesso. Era come una vera e propria sirena: bellissima e crudelissima allo stesso tempo, una vera e propria arpia. Sulla faccia della contessa si formò un ghigno di piacere, mentre passava le sue dita scheletriche sui muri. Ognuno era intriso di un grido di dolore diverso: quello del fornaio, il suo ultimo amante e le cui urla erano le più forti e le più strazianti, si facevano sentire sotto un quadro raffigurante la Vergine, dove il suo cuore aveva preso a battere allo stesso tempo di quei lamenti quando aveva baciato per la prima volta Matelda. Ora la Vergine assomigliava più a una mummia, la faccia era stata bruciata e aveva assunto un aspetto deformato, quasi come quelle che molti pittori davano a molte figure dell’Inferno. Dall’unico occhio che era rimasto a quella Santa, colò giù una piccola lacrima, rossa e densa, quasi nera e dall’odore pungente. La contessa la prese con l’indice e se la mise sulla lingua: quel sangue le rievocava così tanti ricordi! Si voltò un secondo, per poi procedere in silenzio verso le prigioni. Lì c’era un immenso tavolo di pietra, con delle catene su entrambe le estremità. Lì era dove portava i suoi amanti, quando aveva finito di giocare con loro. Non poteva permettersi che se ne andassero a raccontare la personalità frivola della contessa! All’inizio li faceva cadere in una botola piena di lame, ma non provava gusto ad ucciderli così. Dovevano soffrire di più ed era per questo che aveva fatto costruire quel tavolo delle torture. Lo accarezzò, un atto affettivo per spolverarlo, ma sapeva che qualsiasi sua azione ormai non aveva più alcuna conseguenza nel mondo dei mortali. Ci si distese sopra, raggomitolandosi nell’angolo destro in alto, come da viva faceva quando non riusciva a trovare una posizione comoda nel suo letto. Aveva sempre odiato dormire, non le piaceva passare così il momento del giorno più bello: la notte. Da bambina, ricordava, usciva sempre di nascosto dalla residenza del padre, vicina ad Arezzo, per andare a prendere il suo cavallo e cavalcarlo fino a che non fosse sorto il sole, così da tornare in tempo a casa senza preoccupare nessuno. L’unico che le aveva fatto apprezzare il dormire era stato Stefano, il giovane stalliere. Qualche giorno dopo la festa del suo sedicesimo compleanno, Matelda era corsa verso le stalle del palazzo paterno per distrarsi un po’: tutti le stavano addosso, desiderosi di volerla maritare a chissà quale principe o duca. E Stefano era lì, con le mani sporche di terra e due secchi d’acqua per dissetare i cavalli. Quando la vide arrivare cercò di imbellirsi il meglio possibile, ma qualcosa gli aveva detto che la principessina non cercava quello. Quando la vide in lacrime, prese uno straccio per pulirsi le mani, le si accostò e le chiese se volesse parlare. In un primo momento Matelda gli disse tutto, riversò tutto quanto il disgusto che provava nel dover sposare qualcuno contro la sua volontà. Fece poi un passò indietro, rendendosi conto che stava parlando con uno stalliere. Ma lui l’abbracciò prima che potesse urlargli qualcosa, accarezzandole i capelli e dicendole che sarebbe andato tutto bene. Forse era per la luna piena che gli illuminava gli occhi, forse era per la sua spontaneità, forse per quel sorriso così sincero, tutto differente da quello di cortesia dei suoi spasimanti. Forse era perché aveva la mente offuscata dal pianto, forse non era proprio in sé quella sera, forse… forse si stava solo inventando delle scuse per non accettare l’evidenza, che si stava affezionando a lui. Continuarono a vedersi di nascosto in quei mesi: lei lo andava a trovare la sera e lui la portava in posti che non aveva mai visto fino ad allora. Gli cucinava dolci per sfamarlo in quel periodo di carestia. Lo curò dai malanni ben frequenti tra la plebe, e lui la ricompensò facendole vivere tutto il possibile durante le ore di luce, così che potesse imparare a dormire. E le si metteva accanto, cingendola a sé, cantandole mille filastrocche per farla addormentare, così, sorridente e felice tra le sue braccia. Ma poi accadde che lei venisse promessa in sposa ad uno dei conti Guidi, per di più molto avanti con gli anni. Tra un ultimo bacio rubato e un abbraccio frettoloso, i due si promisero di non abbandonarsi, nonostante quell’avversità. Ma quando, tornata da Poppi nel suo paesino d’infanzia, lo trovò tra le grinfie di una contadinella, la rabbia prese il sopravvento e così lo uccise, con la lama più affilata che aveva trovato nelle vicinanze. Mai nessun piacere, nessuna soddisfazione così grande aveva mai travolto quella mente contorta. E così, da quel giorno, aveva iniziato ad uccidere tutti i giovani che somigliavano al suo Stefano con delle lame simili a quella del suo delitto. Ma quando iniziarono a scomparire anche i ragazzi di Poppi, dove alloggiava con il conte Guidi, la gente, insospettendosi, mentre il marito era lontano per motivi bellici, la prese e la rinchiuse in quella torre, murandola viva e gettando le chiavi nell’Arno.
Matelda avanzò fino al portone d’ingresso, valicandolo con innocente disinvoltura. Nel giardino del castello, davanti a lei, risuonavano i colpi di spada di quei famosi duelli combattuti per ordalia o per dimostrarsi all’altezza di prendere la mano di qualche bella fanciulla. Riecheggiavano in quella valle, incessanti. Iniziò a nevicare. Ogni piccolo fiocco di neve, così piccolo eppure così unico, volteggiava lento nell’aria, scosso da una folata di vento, colpito da un suo simile. Si posavano sul lungo abito bianco della contessa, mimetizzandosi, per poi oltrepassare quasi subito quella figura, ormai inconsistente. Ella rise, consapevole del fatto di esserlo stato anche da viva: un cuore inconsistente, leggero e freddo proprio come quei fiocchi di neve non era una novità. Aveva nevicato anche il giorno della sua cattura. Nonostante le urla della plebe, i tentativi di vecchie madri e di vedove di ucciderla prima del dovuto, nonostante il muro di mattoni si facesse sempre più alto, lei non aveva battuto ciglio. Sapeva che si sarebbe vendicata, e per questo, nel suo morir di stenti, morì anche con il suo perfido ghigno in faccia.
Era una sera di plenilunio. Matelda salì le scale della sua torre, si affacciò al suo balcone. Distese le sue mani sul parapetto, contornato di muschio e invaso dagli insetti. Annusò quell’aria di marcio, saturata dall’odore di un cadavere in decomposizione che pareva non volesse lasciare quel posto. E quando la luna raggiunse l’apice, su quella torre, ella urlò. Urlò di tutta quella rabbia che aveva dentro dalla scorsa luna piena, sovrastando gli ululati dei lupi che sembravano tacere nell’udire quel terrificante suono che trapassava l’aria. Il duello presso il castello sembrò fermarsi, la vita stessa sembrò congelarsi, come a sentirsi minacciata. Le urla cessarono, consapevole Matelda che quella notte, in quel paesetto, un ennesimo uomo sarebbe morto.
Ginevra Comanducci
Classe 2C – Liceo Classico “Galileo” di Firenze